Perché i Vesuviani scelgono di vivere su uno dei vulcani più pericolosi al mondo? Claire Power, fotografa dalla formazione letteraria, con il suo progetto “la Montagna”, realizzato nell’arco di tre anni, si addentra nell’atmosfera magica del Vesuvio, silenzioso, ma sempre in agguato: Montagna “madre e matrigna” di un luogo dove uomo e animali coabitano, tra rituali e tradizioni.
Foto copertina: © Claire Power, dal progetto “la Montagna”. Esposto da Effe22 nell’ambito della rassegna di mostre fotografiche in collaborazione con Padova Jazz Festival e Caffè Pedrocchi.

“La Montagna è un luogo incantato dove l’essere umano si confronta con il mistero della propria esistenza: l’essere contemporaneamente fuori e dentro natura. Cacciato dall’Eden, l’uomo esercita ancora il diritto divino di padrone su tutte le bestie e le piante a cui ha dato nome. Ma l’uomo lavora la terra col proprio sudore e alla terra è destinato a tornare.
Non c’è luogo dove l’illusione dell’onnipotenza umana sia così fragile come alle falde dello sterminator Vesevo, secondo Leopardi. La potenziale catastrofe soggiace alla vita tellurica dei suoi abitanti, sempre sull’orlo della dissolvenza. L’addomesticano come possono chiamandolo “A muntagna”. Il progetto segue le tracce di una storia agricola antica che si trasmette nei rituali cristo-pagani, nel sangue e nei gesti, nella relazione tra esseri e terra. Si manifesta in un’esperienza quasi tattile che ricorda la fatica e la cura e ci riporta al corpo come inevitabilmente legato e pienamente immerso nel mondo materiale.
Le immagini evocano elementi magici incorporando superstizioni e mitologia, pozioni e riti immaginari di comunione e divorzio.
Le fotografie si richiamano in un gioco di corrispondenze che trasfigura i soggetti rendendo più labili i confini tra il materiale e il simbolico, tra l’essere umano e il naturale.
Il Vesuvio, quasi invisibile nelle immagini, rimane una presenza costante ma sotterranea, silenzioso ma vivo, nascosto, in agguato.“

Claire Power, nata a Napoli, ti rechi per studi in Gran Bretagna, dove segui anche un Master di fotografia a Londra. Il tuo nome, tanto artistico da sembrar quasi uno pseudonimo, svela da subito questo tuo legame con l’Inghilterra. Mi hai detto che tuo padre era di origine Irlandese e tua madre di Portici, località in provincia di Napoli, sotto il Vesuvio. Pensi che le tue radici inglesi, a cui sei rimasta legata, ti abbiano dato un punto di vista diverso da quello che avresti avuto rimanendo soltanto in Italia?
Non è semplice immaginare cosa sarebbe stato diverso se fossi rimasta. Sicuramente, hanno avuto un grande impatto sulla mia ricerca idee incontrate durante il mio percorso universitario, dagli approcci teorici in ambiti come la geografia e la sociologia alle questioni etiche legate alla propria relazione con i soggetti e la loro rappresentazione che necessariamente informano anche la pratica.
Più in generale, avere un’identità culturale “doppia” mi ha spesso fatto sentire fuori luogo in entrambi i posti. Credo, però, che questo tipo di disagio possa rivelarsi uno stimolo ad una ricerca più approfondita, sollecitata da un lato, da un senso di appartenenza — il legame emotivo alle proprie origini — dall’altro, invece, da una distanza che riaccende la curiosità verso il familiare per rivisitarlo sotto nuovi punti di vista.
Nel mio caso, ero sempre stata ossessionata dal Vesuvio, ma da una posizione unica di timore, per cui ero informatissima a livello geologico o sui piani di evacuazione — una prospettiva istituzionale, numerica, aerea — rimanendo però priva di una concreta visione del vissuto collettivo del territorio dal punto di vista culturale ed affettivo. È solo dopo essermi allontanata che ho cominciato a dirmi “ci deve essere qualcosa in più che rende i vesuviani così ostinati a vivere su uno dei vulcani più pericolosi al mondo.” Mi sono resa conto che per me era un mistero.

Laureata in letteratura inglese, nel tuo progetto citi Giacomo Leopardi, che nella Ginestra parla dello “Sterminator Vesevo”. L’atmosfera delle tue foto ci cala in un contesto quasi fiabesco e, in qualche modo, anche letterario. Le ricondurrei alla categoria del “Realismo Magico”. Quanto la tua formazione letteraria ha inciso nel tuo lavoro di fotografa e nel tuo modo di vivere e interpretare la fotografia? Quanto fotografia e letteratura sono interconnesse nei tuoi scatti?
La letteratura, in particolare la narrativa, è stato il primo strumento con cui ho potuto fare esperienza del mondo oltre la mia sfera personale. Proprio fiabe e miti sono tra le prime storie a cui sono stata esposta e forse tra quelle più comunemente riconoscibili a livello collettivo.
Che sia reale, immaginaria o fantastica, una storia cerca di farti immergere nella vita di altre persone al di là di una conoscenza meramente intellettiva, coinvolgendoti emotivamente per farti vestire, per un momento, del loro punto di vista. E in questa connessione tra sé e l’altro, tra esseri umani, si può scoprire qualcosa di più su sé stessi e sulle nostre visioni del mondo.
Quando la fotografia è entrata nella mia vita ho vinto un nuovo mezzo di esplorazione, dapprima tramite le storie raccontate dagli altri e, poi, con la possibilità di vivere delle esperienze in prima persona e condividerle con altri, avendo a mia disposizione degli strumenti narrativi già familiari.
Anche se tecnicamente differenti, i mezzi che letteratura e fotografia utilizzano per generare pathos mi sembrano fondamentalmente simili: luce e colore prendono il posto del suono in poesia, la sinestesia ci fa sentire l’odore di fumo tramite lo sguardo, l’accostamento di immagini può dar luogo a ossimori e parallelismi, la loro sequenza o disposizione stabilisce un ritmo, citazioni e riferimenti aprono ad un contesto storico e culturale al di là del “testo”.
In particolare penso che l’immagine fotografica abbia un ammirevole potenziale metaforico: è capace a volte, eroicamente, di divincolarsi dal legame ineluttabile col suo referente, dal peso dell’essere — più di un testo scritto — “un certificato di presenza”, e trasformare, nonostante la propria natura, la realtà in qualcosa d’altro.

Trovo molto interessante l’idea di esplorare questa contemporaneità tra materiale e simbolico, come pure i vuoti di contesto che si possono creare giocando con i limiti strutturali dell’inquadratura, sfruttando l’ambiguità e il mistero che ne conseguono per aprire lo scatto alla suggestione ed espanderne gli orizzonti interpretativi.
In questo progetto, così, ha senso per me associare il fiabesco a una fotografia di tipo documentarista come tentativo di arricchire il visibile rivelando la magia racchiusa nei soggetti, cioè quegli elementi immateriali di una cultura che sono alla base e contribuiscono a formare il nostro immaginario collettivo.

Questa atmosfera fiabesca mi rievoca certe scene che ritroviamo nel cinema di Matteo Garrone. Nel tuo lavoro campeggia il colore rosso. Un rosso che, stante il tema, è estremamente significativo. È un rosso fiabesco, ma anche un rosso emblematicamente pompeiano; un rosso che è, chiamando in causa il bel testo di Alessandra Troncone (“LAB03: Tra parole e immagini”, in Biasucci A. (ed.), Epifanie / 03, Giannini Editore: Naples 2021.), vita, sangue, sangue della terra; è pomodoro, ma anche lava. È un rosso che racconta la montagna vulcano, madre e matrigna; un colore che abita queste terre. Quali sono le sue valenze e i suoi simboli nelle tue fotografie?
Devo dire che nel progetto sono presenti varie serie di colore: il rosa che qui è legato all’innocenza e la cura, l’azzurro ad una disperazione esistenziale, il verde ad una natura prevalentemente benigna.
Il rosso che emerge preponderante ha riferimenti ad elementi emblematici del territorio e rappresenta per me il dionisiaco, una natura esplosiva, di vitalità, emozione e caos. In questo modo il rosso è diventato anche il colore dei riti, dei miti, delle feste e delle superstizioni, quegli elementi che si sono trasmessi nel corso delle epoche e che ancora informano modi di vivere nel presente.

Così ho collezionato un satiro che danza con delle caprette, una Venere distesa su un carro di carnevale — una festa primaverile che ci suggerisce il risveglio della natura e la fertilità — ma anche riferimenti, forse meno conosciuti fuori dal territorio, come quello ad una superstizione che impedisce alle donne che hanno il ciclo di partecipare ad una qualsiasi fase della preparazione delle conserve di pomodoro perché si crede rovineranno il prodotto.

Ci conduci per mano in una realtà magica che sembra sospesa nel tempo: uomo e natura convivono, accompagnati da riti pagàni e antichi, in cui il Vesuvio è femminilizzato ed eufemizzato, “‘a muntagna” appunto, che diventa un’immensa sposa per il suo popolo; vuoi parlarci di questo rapporto fantastico e di questa comunità in cui la vita e la morte si intrecciano così saldamente?
Il Vesuvio è una figura particolare per il suo popolo: un padre potenzialmente burbero, una madre generosa che offre un clima mite, frutta deliziosa e vino inebriante, e per molti un semplice sfondo. Alle sue falde troviamo circa 700.000 abitanti solo nella Zona Rossa, quella di maggiore pericolosità in caso di eruzione, la maggior parte ammassati nelle città, le quali hanno avuto un’esplosione demografica nel dopoguerra che ne ha reso certe aree tra le più densamente popolate d’Europa. Con l’ultima eruzione nel ’44, molti l’hanno vissuto prevalentemente come un gigante addormentato, la cui fama attira turisti da tutto il mondo, ma che i cittadini soprattutto — e spesso le istituzioni — trattano con sfuggevole indifferenza.
Per questo motivo ho rivolto l’occhio a quei luoghi dove la relazione tra montagna e abitanti mi sembrava inevitabile e più ambigua: l’ambiente rurale. Mi ci sono avvicinata con delle concezioni che si sono rivelate banalmente ingenue. Per esempio, non era sempre facile individuare il confine tra spazio cittadino e rurale: al di là del cortile di un palazzo in piena città si apre inaspettatamente una terra che ospita un maneggio, mentre colonie di pavoni occupano un castelletto addentrato nel Bosco di Portici, un comune da 50.000 abitanti in circa 4 Km2. Allo stesso tempo, spesso le persone non abitano le terre che lavorano, molti terreni sono stati abbandonati, alcuni dalla speranza del lavoro in fabbrica, molti frantumati in piccoli appezzamenti dalla geologia o da un passaggio di eredità, e così anche la cultura legata a quelle tradizioni singhiozza. Per cui anche definire la comunità rurale vesuviana dal mio punto di vista è stato parte della ricerca.

Ho cercato di raccogliere le singolarità sparse per il territorio, fossero individui, famiglie o gruppi attivi come collettività, in cui ritrovavo un particolare legame con la terra, per via del lavoro, per una presenza e un uso privilegiato di determinati spazi, per la continuazione o il recupero di tradizioni e riti familiari o collettivi legati al territorio, sia laici che religiosi. Un senso di magia che ho voluto poi trasmettere nel progetto: un’energia, una resilienza, umorismo e un grande desiderio di condivisione che concorrono, o forse sono conseguenti, all’atteggiamento fatalista di coloro che si confrontano quotidianamente con una vita tellurica, quella che Maria Pace Ottieri in Vesuvio Universale descrive come una “vacillante realtà sempre sull’orlo della dissolvenza, della metamorfosi”.

Una fotografia è capace (come vuole il trito cliché) di fermare il tempo. Nonostante questo mantra sia stato rimasticato infinite volte, rimane ancora qualcosa di magico, e, se vogliamo, di rituale, nell’atto di fotografare. Un “carmen”, che ci aiuta a immortalare un momento, ma che, al contempo, lo uccide; un atto che può raccontare (o inventare) una storia; sempre un’interpretare, proprio come la letteratura. Può essere un’azione, in senso lato, capace di sancire l’ordine stabilito delle cose; come il rito, religioso o laico, ci dà un’illusoria salvezza dal Tempo. Ma che cos’è per Claire Power fotografare? Come nasce questa tua passione e come si integra il rito moderno della fotografia nei riti quotidiani, giovani e antichi, della comunità che hai ritratto?
Ho cominciato a fotografare quando mi sono unita alla società di fotografia dell’università e ho scoperto presto che era un modo abbastanza efficiente per giustificare la mia presenza attorno a degli sconosciuti, per sfamare la mia curiosità nei confronti degli altri nonostante la mia timidezza, perché mi permetteva di stare lì ad osservare con un apparente scopo, ma con la possibilità di rimanere relativamente ai margini e in silenzio. Per cui, a livello personale è una scusa per risolvere la mia fondamentale incapacità di vivere cercando risposte nel modo di stare al mondo degli altri.
Anche se la sessione fotografica è decisamente l’aspetto della fotografia che preferisco, la fase dell’editing rimane fondamentale per digerire e rielaborare l’esperienza. William Wordsworth diceva che la vera poesia deriva “dall’emozione rammentata nella tranquillità.” Durante l’editing ci si ferma per far riemergere quello che nello scatto eravamo intenti a vivere per analizzare l’esperienza, il nostro modo di osservarla e rappresentarla. Può essere una gioiosa sorpresa scoprire una nuova modalità di vedere le cose di cui non eravamo al corrente, individuare coscientemente quello che intuitivamente avevamo appreso, e poi cercare di formalizzarlo in un lavoro coerente che catturi l’osservatore all’interno della storia.

Fotografare diventa per me un po’ come fare da guida, nel senso che sei portato a condurre i visitatori lungo un tuo personale itinerario tra gli infiniti possibili, ma comunque all’interno di uno spazio — fisico o tematico che sia — dotato di proprie e specifiche strutture, caratteri, storia, persone. Così ogni lavoro fotografico è un percorso unico in cui le varie tappe sono colorate dall’occhio dell’autore, su cui ricade il compito di creare una connessione tra l’osservatore e quello che gli sta mostrando.
Da un altro punto di vista la fotografia come oggetto, fisico o virtuale, è una delle poche cose che sento di poter offrire ai soggetti in cambio della loro generosissima ospitalità. Lo scambio di foto che testimonino una situazione o un evento diventa un ulteriore strumento di connessione. Ho in mente al momento con questo progetto una mostra cittadina in una comunità in particolare che mi ha accolto più e più volte durante questi ultimi anni in modo da restituire il percorso che abbiamo condiviso. È ancora in progettazione, ma spero con tutto il cuore di realizzarla.

Nel tuo scatto dell’uomo giacente con lo specchio in mano, nei panni d’una Venere biancovestita, distesa su una coltre rossa che è anche un sipario, abbiamo un connubio di elementi differenti che richiamano gli affreschi di Pompei, una romanità antica, una teatralità partenopea ed anche e un qualcosa della fiaba. Lo trovo molto emblematico. Quali sono per te le foto più significative di questo progetto? Il vulcano, fil rouge del racconto, fa sentire la sua presenza in maniera straordinaria, anche grazie e attraverso la sua assenza. Come ci sei riuscita?
Il profilo del Vesuvio è talmente riconoscibile anche fuori dall’Italia che può essere considerato una vera e propria icona. In quanto panoramica, ci posiziona come osservatori in una relazione di distanza dal soggetto. Essendo così famoso non c’era quindi una vera necessità di mostrarlo, ma soprattutto volevo assumere una prospettiva più interna e ho la sensazione che il vulcano non sia coscientemente presente nel vissuto comune. Di fatto, alcune tra le relazioni più attive con il complesso vulcanico a cui ho assistito sono con il Monte Somma, la cima antica che ora costituisce una sorta di semicerchio attorno al Vesuvio. Infatti, nell’unica foto del progetto in cui questo si intravede, il punto di vista è proprio quello dal Monte Somma, durante una delle feste popolari che vedono gli abitanti di alcune comunità celebrare l’evento sulla sua cima.
Non credo di saper definire le foto più significative in assoluto perché penso che il senso del progetto sia più nella sua narrazione, nella sequenza e interazione tra le immagini. Ce ne sono alcune però che sono diventate riferimenti personali per la direzione del progetto.
C’è una foto in cui, ad un primo sguardo, sembra di assistere ad un funerale. Se espandessimo l’inquadratura sarebbe evidente invece che è una messa in scena parodica, parte di una tradizione locale carnevalesca. C’è un accenno nell’immagine stessa all’atipicità della situazione, un fallo di legno che emerge dal fumo, ma non talmente evidente da rompere l’illusione in toto.
Questa decontestualizzazione attraverso una scelta dell’inquadratura che esclude è diventata parte del linguaggio del progetto, un modo di trasformare il soggetto al di là della rappresentazione didascalica legata allo specifico evento e luogo.

O, per esempio, alcune immagini che trasmutano il soggetto per ricollegarci ad un’iconografia e una mitologia che ci lega al passato, come la Venere a cui facevi riferimento, o una come quella del velo nell’erba che mi ha fatto rendere conto della possibilità di sfruttare la dualità della fotografia come rappresentazione diretta del suo referente e contemporaneamente segno che può rimandare ad altri significati, per giocare con diversi livelli di riconoscibilità e interpretazione. Chi lavora localmente con la terra può riconoscervi una rete antigrandine che serve a proteggere gli alberi da frutta. Per altri non sarà così familiare e potrebbe evocare invece un matrimonio. Senza dover aggiungere una spiegazione, ma rimanendo ancorati al mondo reale, ho tentato di evocare la relazione di cura tra il contadino e la terra, una sensazione emersa dalla mia esperienza intellettiva ed emotiva di quella situazione. Sopratutto, mi piace l’idea che, senza escludere nessuno dall’approcciarsi all’immagine, un osservatore locale possa avere un pizzico in più di conoscenza rispetto all’osservatore esterno.

La Montagna, il Vesuvio, dove Eros e Thanatos si fondono, è un luogo ricco di simboli, e per ciò stesso Sublime. Anche le sue vette, propriamente, lo sono. I suoi abitanti, che sembrano usciti dal mito edenico, attingono al Sublime attraverso una natura quasi incontaminata, attraverso una “frugalitas” che per noi urbanizzati ha il sapore di una fiaba. Ma la categoria del Sublime è, per ognuno, estremamente soggettiva. Per Claire Power, che cos’è il Sublime, e come ti piace raccontarlo?
I vulcani erano una delle rappresentazioni tipiche del Sublime, di quella natura terrificante e intensa, che ricordava all’uomo la sua impotenza e l’essenza effimera della propria esistenza, per cui penso mi abbia influenzato molto come concetto in questo progetto.
Anche se non evidente nella maggior parte delle immagini singole, credo che emerga nella narrazione complessiva: l’evocazione di elementi del Sublime come la lava, il fumo, la distruttività convivono con immagini legate al Bello, trasmettendoci una sensazione di pace e benevolenza, situazioni che vengono rese più precarie dai rimandi alla minaccia sotterranea e silenziosa del vulcano dormiente.

Rispetto ai tempi del Romanticismo però l’essere umano ha acquisito a sua volta un potere sulla natura inimmaginabile all’epoca e trovo la nostra violenza altrettanto terrificante. Per questo, molto spesso le immagini che evocano maggiore brutalità e devastazione nel progetto sono in realtà legate all’azione delle persone. Per quanto sia possibile instaurare delle splendide relazioni di armonia e cura con l’ambiente, oggi le azioni della nostra specie sulla natura animata e inanimata sono diventate a loro volta fonte di quelle emozioni che animano il Sublime e ne stiamo subendo le conseguenze sulla nostra pelle, dal Covid agli effetti dirompenti del cambiamento climatico. Queste tematiche sono estremamente urgenti da esplorare quando la sopravvivenza della nostra e di altre specie è in discussione. Proprio il Sublime potrebbe essere una delle categorie estetiche adatte ad affrontarle.


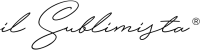


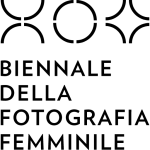











Anna Scarano
Cara Claire le tue foto sono uno spettacolo! La prossima volta fammi sapere per tempo dove esponi, che, se posso, verrò volentieri ad ammirare dal vivo. Complimenti e tanti cari auguri di buon Natale!